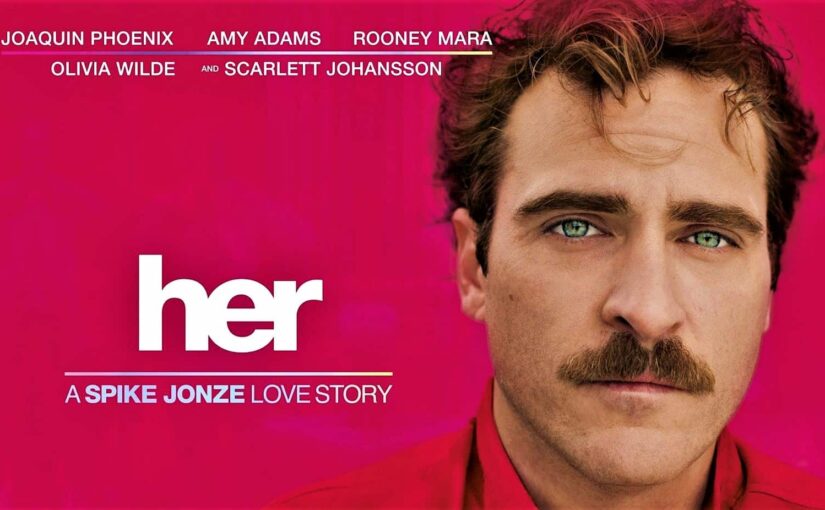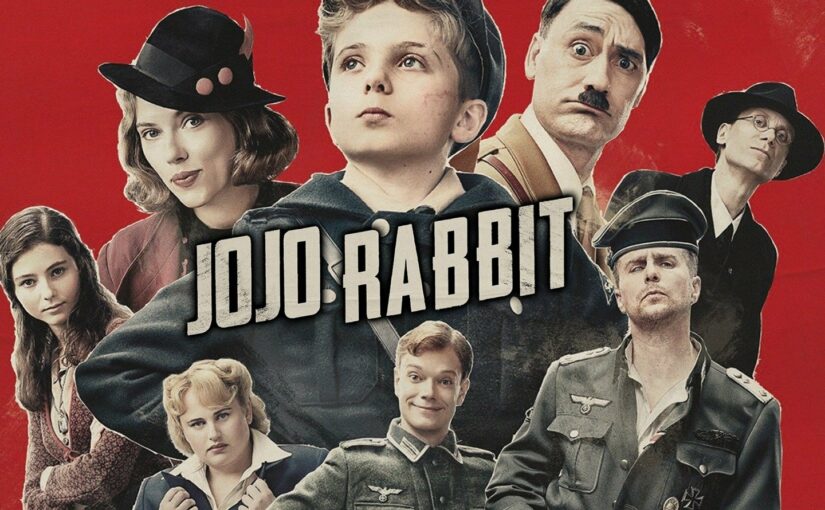Conosci Captain Fantastic? No, non è l’ennesimo supereroe, ma il titolo di un film del 2016 con Viggo Mortensen come protagonista, dove l’attore interpreta il ruolo di Ben, un padre di sei figli.
In questo nostro tempo, che qualcuno ha definito caratterizzato proprio dall’assenza della paternità, con tutto ciò che questo termine significa nella realtà e simbolicamente, questa storia punta tutto invece su un padre.
In estrema sintesi il film racconta di una famiglia molto sui generis che decide di crescere i figli in una foresta del Nord America, lontano dalla cultura dominante, e proponendo un proprio modello educativo alquanto originale e decisamente radicale, dove non sono previsti l’elettricità (tanto meno device elettronici) e festività tradizionali come il Natale, ma lo sono ad esempio la caccia a mani nude e la venerazione dell’intellettuale Noam Chomsky.
Se all’inizio sembra funzionare tutto in maniera quasi idilliaca, ben presto succede qualcosa (tranquilli, non spoileriamo) che inizia a incrinare questo modello educativo, anche se nello scorrere del film continuano ad esserne evidenti pregi da un lato e difetti dall’altro. Proseguendo nella storia poi, si arriva ad una crisi definitiva quando gli insegnamenti paterni fanno incorrere in un grave pericolo un membro della famiglia. A questo punto il limite di questo modello educativo diventa evidente, ma quando tutto sembra solo un grande fallimento, è proprio la capacità del padre di ammetterlo, che permette di ricominciare in un altro modo e mantenere unita la famiglia.
Il film ovviamente è molto più ricco di così, ma per gustarne tutte le emozioni e le scene irriverenti che contiene, vi invitiamo a guardarlo (se non lo avete già fatto).
Ora quello che vogliamo sottolineare sono proprio i tratti paterni che emergono, al netto delle “particolarità”.
Innanzitutto Ben è un padre di sei figli: basta questo per dire che non si limita al minimo indispensabile per diventare padre, ma è generoso, non ha paura di dare la vita, non ha paura di perderci (i propri spazi, il proprio tempo, i propri soldi, ecc..) perché sa che nel donare la vita non la si perde ma la si guadagna.
In questo “guadagno” c’è sicuramente anche il fatto che ogni figlio porta una sua bellezza e una sua ricchezza specifica alla famiglia. Nel film ciò è rappresentato dal fatto che ogni figlio suona uno strumento musicale diverso, come a dire che ognuno ha una personalità diversa che “suona” in maniera differente, e può offrire il suo personale contributo alla “melodia” famigliare.
Inoltre, è interessante notare che, nonostante la madre non sia presente fisicamente (vedendo il film capirete perché), la sua presenza si percepisce in tutto il film, proprio perché Ben non è un padre single: anche se solo, è un uomo che è divenuto padre attraverso una donna, sua moglie. È la coppia che ha generato, è la sua donna che lo ha reso padre ancora prima dei suoi figli. Anche questo è un tratto che spesso si dimentica: la paternità è un dono che arriva sempre dall’unione con una donna, è frutto di un dono reciproco, e questo la rende più libera perché la rende appunto “frutto” e non risultato o traguardo di un proprio progetto personale.
E come fa il padre, Ben?
Innanzitutto educa personalmente i suoi figli e si gioca in prima persona, anche sugli argomenti più scomodi come la morte o il sesso. Insomma, non delega a nessuno questa sua responsabilità paterna, ma se ne assume tutto il carico, facendo anche degli errori certo, ma mettendocela tutta.
In questo suo impegno educativo mostra vari tratti di una paternità vissuta autenticamente e pienamente e che potremmo riassumere in questi punti:
- Non ha paura di parlare con i figli, di presentargli la realtà così com’è, e non si sottrae alle loro domande, ma si fa trovare, così come egli non manca di fare domande a loro. Con metodo maieutico infatti, li ascolta e chiede loro lo sforzo di esprimere il proprio pensiero e di sostenerlo, non si accontenta di risposte superficiali o da slogan.
- Non teme di mettere i figli davanti alla realtà della morte come parte integrante della vita.
- Non ha paura di esercitare la sua autorità (dal latino auctor cioè “colui che fa crescere”), non ha timore di prendere una posizione netta: nell’educare trasmette i suoi valori, un po’ strampalati in questo caso, ma che hanno il pregio di essere consistenti, trasmettendo ai figli un’etica solida e coerente, che loro potranno in futuro accogliere o contestare.
- È capace di sintonizzarsi sulle emozioni dei propri figli, cioè di percepirle, riconoscerle e validarle. Li “vede” anche da questo punto di vista, non vede solo le sue aspettative su di loro. Magistrale in questo senso è la scena di sintonizzazione emotiva attorno al fuoco all’inizio del film: Ben iniziare a suonare la chitarra proponendo un ritmo, ma si dimostra pronto a cambiarlo nel momento in cui uno dei sei figli ne esprime uno diverso, suonando le percussioni ed esprimendo la propria rabbia. Tutta la famiglia a quel punto si sintonizza su quel ritmo e su quell’emozione, facendo sentire accolto e validato lo stato emotivo di Rellian.
- Ben è anche un padre che a suo modo trasmette il maschile ai propri figli maschi: con la lotta e la caccia passa loro la gestione dell’aggressività, e quando il figlio maggiore parte per farsi la sua vita, gli fa un conciso e diretto “discorso” da uomo a uomo su come trattare (con rispetto) le donne.
- Inoltre è un padre che non ha paura di andare controcorrente rispetto alla cultura che abita. Nel film questo è certamente un’iperbole, ma ci offre un insegnamento prezioso perché, se è vero che tutti, in quanto figli, ereditiamo una cultura, è altrettanto vero che una volta adulti, siamo legittimati a diventarne padri, ovvero ad elaborane una nostra visione e ad offrire un nostro personale contributo. Anche questo ci sembra un importante compito a cui essere iniziati proprio in famiglia.
- Infine, è un padre che sa riconoscere i propri limiti e da questi si fa mettere in discussione. Questo è uno degli insegnamenti più forti del film: Ben è un padre che sa ammettere i suoi errori e sa chiedere scusa e questo, anziché fargli perdere autorevolezza davanti ai propri figli, al contrario gliene fa di nuovo guadagnare la stima. Infatti, come si vede nello snodarsi del film, non è il fallimento che crea una rottura con i figli, ma la sua negazione. Ed è riconoscerlo e ammetterlo che fa recuperare la stima e la relazione con i figli.
Captain Fantastic insomma ci è piaciuto perché racconta una paternità autentica, non perfetta, ma vissuta in pienezza, con audacia e forza, e capace di compiere il passaggio più grande (e più difficile): passare da una paternità autocentrata che vede i figli in funzione del proprio progetto, ad una paternità decentrata che rinuncia al proprio progetto per mettersi al servizio di quello che ogni figlio vorrà liberamente intraprendere.
È quindi un film che incoraggia ogni uomo a diventare padre nel senso più pieno del termine: non è generare un figlio (o sei figli) che rende padri, è assumersene tutta la responsabilità, con i propri limiti ed errori, certo, ma non sono questi che compromettono la paternità, nel momento in cui ci prende la responsabilità anche di quelli.
GENERATED BY HUMAN INTELLIGENCE