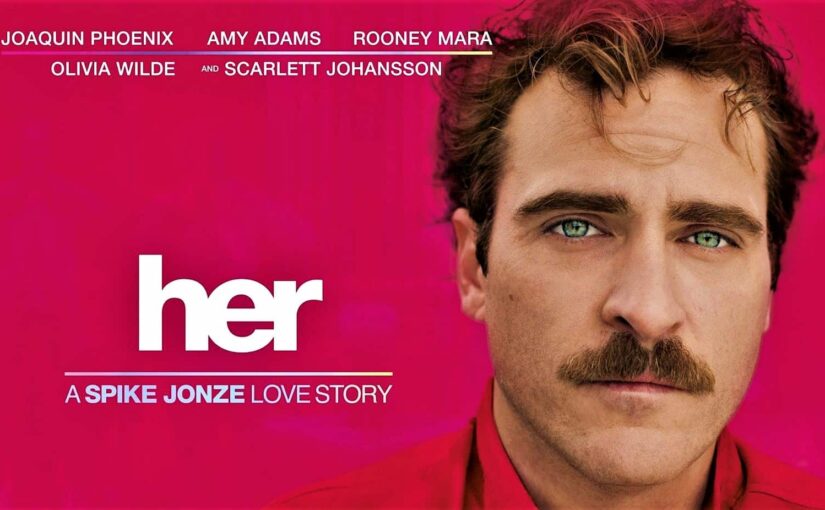Per fortuna ci sono ancora
genitori che si preoccupano dell’educazione sessuale dei propri figli.
Sebbene noi di figli non ne abbiamo, più volte ci sono stati chiesti consigli al riguardo. Le domande spaziavano da «a quale età bisogna iniziare a parlare loro di sesso» fino a «cosa dire a tuo figlio quindicenne che fa uso di pornografia». Probabilmente però la domanda più ricorrente è quella sugli strumenti: «avete del materiale che spieghi come parlare ai figli di sessualità?».
E forse il punto cruciale è proprio questo: parlarne. Ma è solo un problema di come e quando parlarne? È solo un problema di cosa dire? Vediamo di ragionarci un po’ insieme.
Intanto vale la pena sottolineare che va apprezzata questa preoccupazione da parte dei genitori.
Non è scontata: c’è chi si limita a raccomandare l’uso del preservativo (per i figli maschi) e a far prescrivere dal ginecologo la pillola contraccettiva (per le figlie femmine). E crede che sia sufficiente così, tanto al genitore in questione mica gliel’ha insegnato qualcuno come funziona quella roba lì, e tutto sommato se l’è cavata, perché non dovrebbe funzionare così anche per suo figlio/a? (che poi bisognerebbe capire cosa vuol dire che “se l’è cavata”).
E poi c’è il genitore che invece, al comparire del primo fidanzatino della figlia quattordicenne che fino al giorno prima pensava solo ai compiti e alle amiche, va nel panico totale perché il tema dell’affettività e della sessualità gli si paventa davanti all’improvviso come un mostro brutto e cattivo che si presenta senza appuntamento, ma che chiede di essere affrontato. E davanti al quale il genitore in questione si sente terribilmente disarmato.
Ancora, c’è il genitore, per lo più di estrazione cattolica, che vorrebbe tanto parlare di affettività e sessualità al proprio preadolescente o adolescente, ma proprio non sa come fare: vorrebbe trovare le parole ad effetto e gli esempi giusti per trasmettere valori, grandi proposte e ideali, ma non sa da dove cominciare, perché nessuno lo ha mai fatto con lui e l’imbarazzo lo paralizza. E quindi spera tanto che l’argomento venga affrontato in parrocchia, a scuola – a certe condizioni – insomma, spera tanto che qualcuno lo faccia al posto suo, o almeno che gli fornisca gli strumenti, le parole, un piccolo vademecum, qualsiasi cosa, per potersi barcamenare in questa impresa che sente completamente fuori dalla sua portata.
Poi ci sono i genitori che sanno
esattamente come cavarsela e quindi non hanno bisogno di leggere questo
articolo (o forse sì?).
Cari genitori, capiamo bene la vostra preoccupazione, ma abbiamo una buona – speriamo – notizia per voi. L’educazione sessuale dei vostri figli inizia molto, ma molto prima che il mostro di cui sopra vi bussi alla porta, e una grande parte di questa educazione non richiede sforzi o particolari competenze perché non riguarda cosa dire, né come dirlo, ma riguarda ciò che voi stessi trasmettete con la vostra vita, senza bisogno di discorsi ad effetto o parole di persuasione.
È vero, ci sono tante altre cose
che i figli imparano fuori dalle mura di casa o sul web, ma la “parola fatta di
carne” che vedono in voi, come singoli e come coppia, è solo vostra, e in
quanto tale, insostituibile.
Ecco allora 4 punti su cui potete riflettere innanzitutto per voi stessi e poi per l’impatto che questo ha sull’apprendimento esperienziale dei vostri figli.
1) Come mi sento rispetto al tema della sessualità?
È una domanda importante perché riguarda il tono emotivo con cui, come adulto, mi approccio all’argomento. Se sono a mio agio in questa dimensione della vita infatti, sarò meno spaventato, meno imbarazzato, meno a disagio nel parlarne. Questo permette innanzitutto che la sessualità non sia un argomento tabù in famiglia, ma che possa essere un argomento di conversazione sereno, aperto, senza creare momenti di imbarazzante silenzio o una sottile sensazione di colpa o inadeguatezza. Sereno e aperto non significa rinunciare alla grande dignità e intimità che questo argomento richiede, ma far sì che non alimenti il senso del “proibito” sollecitando emozioni quali la paura (ad esempio la paura di sentire, la paura del piacere, la paura dell’altro sesso…) o il senso di colpa rispetto a sensazioni, risposte corporee, emozioni, del tutto fisiologiche e normali.
Allora, più io come singolo e noi come coppia viviamo bene questa dimensione della nostra vita, più sarà facile trasmettere un messaggio positivo ai nostri figli, un messaggio che passa soprattutto dal sentire e che rende le nostre – eventuali – parole, credibili.
2) Che uomo/che donna sono? Cosa trasmetto rispetto alla mascolinità e alla femminilità?
Educazione sessuale significa anche educare al maschile e al femminile. È interessante e utile allora, chiedersi che messaggio stiamo trasmettendo rispetto a questo. Come donna e madre, cosa sto trasmettendo ai miei figli, femmine o maschi che siano, rispetto alla femminilità? Cosa mostro loro rispetto all’essere donna? E rispetto alla mia relazione con il maschile? Lo valorizzo o lo svaluto? Le stesse domande valgono anche al maschile, naturalmente.
È un discorso un po’ complesso e
variegato ma possiamo tentare di semplificarlo con un esempio, in questo caso
al femminile.
Se sono una donna che tendenzialmente subisce nella relazione e si mette sempre in disparte e in secondo piano rispetto al marito, trasmetto un certo tipo di femminilità, che ha in sé questi tratti, e che ha un impatto, per lo più inconsapevole, sui figli. Una figlia femmina, ad esempio, potrebbe ribellarsi a questo modello in maniera rigida, senza potersi mai permettere una posizione conciliante col maschile, oppure potrebbe ricreare la stessa dinamica legandosi a un uomo che la sminuisca e la “domini”.
Ma ciò non vale solo per le figlie femmine: come donna, il mio modo di incarnare la femminilità ha un impatto anche su un eventuale figlio maschio. Infatti, nel nostro esempio, ciò potrebbe condizionarlo sullo sguardo (seppur inconsapevole) che egli avrà rispetto alle donne e alla sua relazione con esse: ad esempio questo figlio, una volta adulto, potrebbe aspettarsi lo stesso atteggiamento di subordinazione da una futura compagna, proprio in quanto donna.
Insomma, il modo in cui come genitori incarniamo la femminilità e la mascolinità, fornisce dei messaggi (impliciti tante volte) su cosa significa essere un uomo e una donna, e questo è un tema fondamentale dell’educazione sessuale, oggi sempre di più.
3) Cosa mostrate/rivelate sul tema della coppia e dell’amore?
Strettamente legato al punto precedente, questo riguarda proprio la vostra relazione di coppia. Che tipo di coppia siete? Una coppia che si ama o che si sopporta? Una coppia dove ciascuno ha i propri spazi o siete una coppia fusionale? Una coppia dove c’è stima reciproca o velata indifferenza? Come vi relazionate l’un l’altro? Con affetto o con freddezza? Cosa circola tra voi rispetto alla vostra unione: rassegnazione o gioia?
Purtroppo o per fortuna tutti
questi aspetti trasmettono un messaggio sulla relazione di coppia e su che
cos’è l’amore.
Fare esperienza di due genitori che si amano, si rispettano, si dimostrano stima reciproca e si sostengono nei propri progetti personali, fornisce un vocabolario affettivo fondamentale per i figli, fornisce loro un paradigma interiore incancellabile che rimane, nonostante tutti gli altri messaggi che incontreranno nella loro vita. Rimarrà loro dentro l’impronta di come il padre guardava con ammirazione la madre, di come la madre si rivolgeva con tenerezza al padre, di come, per amore, lui si faceva carico di un lavoro domestico e di come lei lasciava a lui, per amore, dello spazio personale per ricaricare le batterie.
In questo caso, l’esperienza che i vostri figli fanno, li tocca molto più di qualsiasi discorso ben confezionato.
4) Come esprimete l’amore attraverso il linguaggio del corpo?
Diretta conseguenza del tema precedente, ma non solo, è l’espressione dell’affettività, soprattutto per quanto riguarda i gesti. Ad esempio, fare esperienza di un padre che non ha paura di abbracciare, accarezzare o baciare la propria donna (e i propri figli naturalmente, ma questo è un altro piano) è una trasmissione fondamentale che passa dal comportamento e non dalle parole. Spesso, quando manca, i figli faticano a farlo a loro volta, e non è questa una parte importante dell’educazione alla sessualità? I gesti della sessualità non sono solo quelli che riguardano il rapporto sessuale: la sessualità è fatta di tantissimi altri gesti quotidiani, che nutrono la coppia di tenerezza, intimità e complicità, e che sono quindi “i preliminari dei preliminari”.
Troppo spesso forse la preoccupazione educativa sembra rivolta solo ai gesti specifici dell’intimità sessuale e non diamo abbastanza importanza all’educare ad esprimere l’amore: questo è parte integrante e basilare di una vera educazione sessuale, che riguarda tutta la persona e tutta la sua capacità di esprimere l’amore con il linguaggio del corpo.
In conclusione, cari genitori, è una bella attenzione verso i vostri figli la preoccupazione nei confronti della loro educazione sessuale. E capiamo la vostra apprensione sul cosa dire loro. Tuttavia abbiamo voluto sollevare questi quattro punti perché troppo spesso la preoccupazione è solo per ciò che i figli respirano fuori casa su questo tema, ma a nostro avviso non si è altrettanti attenti a cosa invece è in vostro potere dentro casa.
Con questo, se non vi sentite dei grandi esempi per i vostri figli, non vogliamo farvi sentire in colpa o sbagliati: sappiamo molto bene che tutti noi abbiamo fatiche, ferite e difficoltà sia personali che di coppia. E sappiamo anche che la realtà è complessa e variegata, e che nessuno vive in una famiglia ideale, anzi.
Il nostro intento è stimolare una riflessione: crediamo infatti che la cosa importante sia sapersi mettere in discussione e non rinunciare a crescere insieme ai propri figli, qualunque sia la nostra situazione di vita.
GENERATED BY HUMAN INTELLIGENCE








![«Maria ci mette nella “postura” corretta per accogliere la vita» [Intervista]](https://teologiadelcorpo.it/wp-content/uploads/2021/05/PXL_20210203_092815086.PORTRAIT-825x510.jpg)